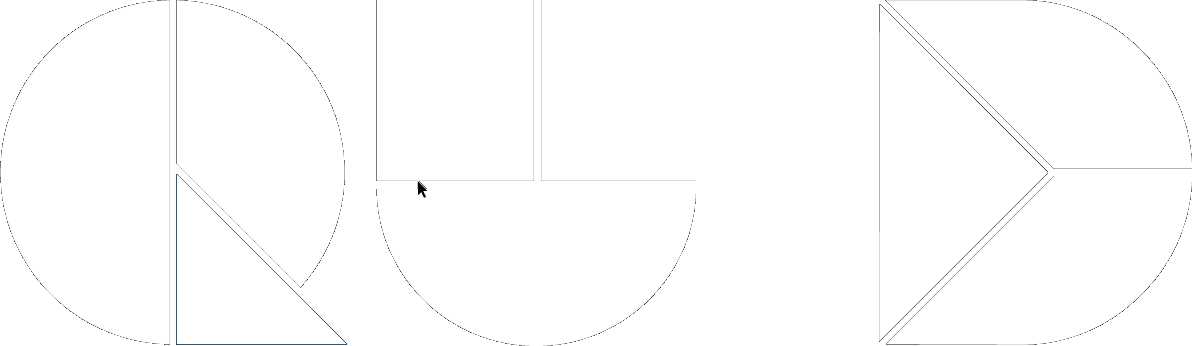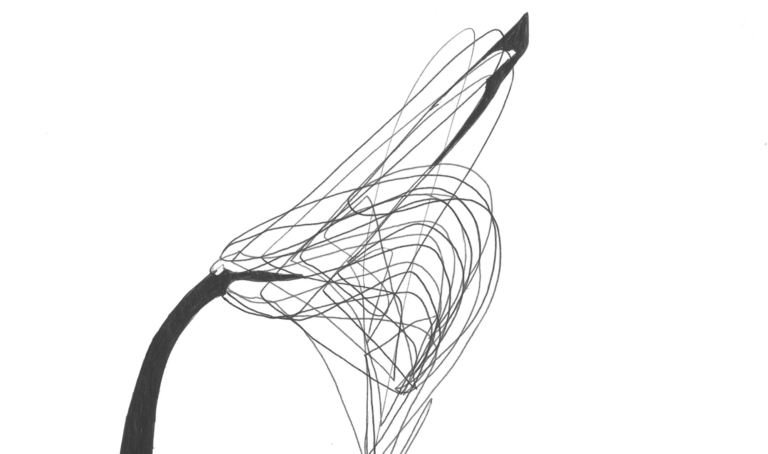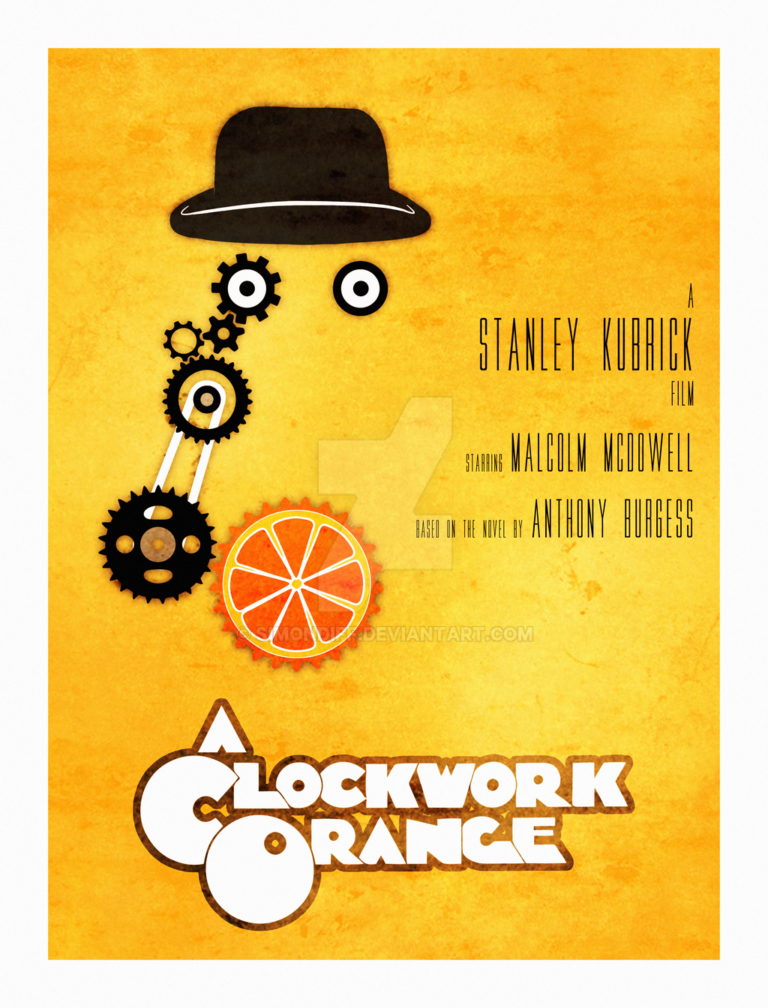Il colore e la sua assenza come imprescindibile elemento della cinematografia
Di tutte le invenzioni di cui il cinema è stato protagonista, quella sicuramente meno impattante, dal punto di vista tecnico, è stata proprio il colore. Non che l’avvento sia stato completamente indolore per le produzioni cinematografiche, anzi, il processo inizialmente era tre volte più costoso dell’analogo in bianco e nero. Però, paragonato a tutti gli altissimi costi e problemi che ha portato il sonoro all’interno dell’industria cinematografica, il colore ha avuto un impatto sicuramente meno devastante. Ma perché qualcuno, a un certo punto della storia del cinema, ha pensato di aggiungere la crominanza alla luminanza?
Il Mago di Oz (1939), pubblicizzato all’epoca come una pellicola “dotata della magia del Technicolor”, è da molti ritenuto il primo vero lungometraggio a colori. Il film inizia in bianco e nero ma quando Dorothy atterra nel regno di Oz, miracolosamente intatta dopo essere stata sradicata da un tornado (ed essere atterrata sopra una strega), trova un mondo incantato di colori.
Un altro esempio, molto più recente, è Matrix (1999). Il film, la cui sinossi è qui inutile ribadire, si svolge in una realtà che assomiglia in tutto e per tutto alla nostra, tranne per il fatto che qualcuno, l’agente Smith ad esempio, è in grado di deformarla a suo piacimento. Non tutti lo notano, ma ogni volta che i protagonisti sono dentro Matrix il mondo ha una tinta verdastra, le ombre sono più scure, e tutto è meno definito, più morbido, come a voler sottilmente indicare di trovarsi quasi in una dimensione onirica.
In Psycho (1960) di Alfred Hitchcock, il bianco e nero è invece ricercato e anche quasi imposto, nonostante il colore fosse ormai lo standard per le produzioni dell’epoca. Psycho è un film che si differenzia dalle altre opere di Hitchcock per un solo particolare: il sangue. Se nel successivo Uccelli (1963) la violenza dei volatili verso gli esseri umani è una riedizione del complesso edipico, che è spesso il leitmotiv della cinematografia hitchcockiana, e il film trabocca di particolari truculenti (come il vicino di casa a cui i gabbiani hanno cavato gli occhi), in Psycho la famosa scena della doccia sarebbe stata troppo terrificante per il pubblico. La censura, impegnata a nascondere le nudità di Janet Leigh, avrebbe trovato un ottimo appiglio per impedirne l’uscita. Il sangue viene quindi semplicemente smaterializzato eliminando la crominanza, il colore appunto, lasciando scorrere nello scarico un liquido scuro della cui natura gli spettatori sono certamente consapevoli, senza però esserne troppo investiti emotivamente. Già in bianco e nero è una scena ad altissimo impatto, ma a colori avrebbe reso arduo allo spettatore impreparato continuare la visione del film. Nella scena successiva la scelta della sottrazione del colore è ancora più evidente: in quasi dieci minuti di meticolosa pulizia Anthony Perkins/Norman Bates si impegna a rimuovere ogni traccia di sangue dal bagno in cui, poco prima, lo stesso Norman con gli abiti della madre aveva compiuto l’omicidio. La scena funziona non solo perché è diretta da Hitchcock ma, soprattutto, perché manca l’identificazione, l’evidenza del reato: Norman sta rimuovendo un liquido che noi identifichiamo esattamente, ma l’operazione che sta compiendo trascende da esso. Quindi il regista riesce nell’operazione, per nulla banale, di trasformare l’assassino nello scrupoloso esecutore di un compito comune come la pulizia del bagno, e nel contempo il pubblico segue attentamente l’operazione per vedere fino a che punto il personaggio sia ossessivo-compulsivo. Il tutto ottenuto semplicemente privandoci della profondità cromatica.
In Schindler’s List (1993), Steven Spielberg racconta la storia di Oskar Schindler, un industriale moravo che salvò più di un migliaio di polacchi-ebraici impiegandoli nelle sue fabbriche durante la Shoah. È una pellicola dalla gestazione travagliata (Spielberg acquistò i diritti nel 1982 ma per anni non si ritenne pronto per dirigerlo) nella quale il regista affronta il suo retaggio e decide di farlo, appunto, in bianco e nero. Questo per suscitare, nelle intenzioni di Spielberg, le emozioni trasmesse dalla visione dei documentari sui campi di sterminio.
Ma, contrariamente all’idea diffusa di un approccio documentaristico alla storia di Oskar Schindler, Spielberg cercava invece una complicata e riuscita crasi tra la narrazione del protagonista, investito dalla Shoah che per lui acquista contorni sempre più definiti, e quella documentata e agghiacciante delle vittime del nazismo. Il bianco e nero e l’uso della camera a mano, apparentemente in antitesi, diventano la cifra stilistica di un prodotto inusuale rispetto alla filmografia del regista americano, il quale, pochi mesi prima, aveva finito di girare Jurassic Park (1993). In una delle scene più disturbanti, una bambina con un cappottino rosso sfugge dalla strage del Ghetto di Varsavia. Con questo singolo elemento cromatico si alza ancora di più il livello della narrazione: il regista ci obbliga, dopo averci mostrato così tanta insensata violenza da averla quasi introiettata, a scostarci dall’ineluttabilità di quello che è già accaduto (e di cui noi siamo due volte testimoni). Lo fa inserendo nella storia un elemento apparentemente fuori contesto: una bambina con un bel cappotto colorato che corre tra i rastrellamenti e le esecuzioni come se nulla di tutto ciò stesse accadendo. E mentre la scena in cui vediamo il cappottino rosso spiccare tra un mucchio di cadaveri potrebbe essere addirittura superflua, non lo è quella finale, a colori, in cui gli attori vengono strappati a forza dal film e si ritrovano sul monte Sinai, ognuno di loro accanto al superstite che ha interpretato, per rendere omaggio alla tomba di Schindler. Il colore funziona adesso come richiamo alla realtà, diventa il passaggio forzato dalla finzione cinematografica alla realtà che, fino a quel punto, è stata quella testimoniata proprio con l’assenza di cromaticità.
Il colore è stato ed è, soprattutto nell’epoca odierna in cui la resa cromatica è superiore alla nostra percezione, un narratore silenzioso, ovvero la possibilità di aggiungere (o togliere) una linea narrativa solamente aggiungendo (o togliendo) un’informazione. È quindi ovvio che il mondo meraviglioso evocato da Dorothy in “Over the Rainbow” sia pieno di colori, in netto contrasto con quello da cui è fuggita e nel quale una strega (dell’est, per essere precisi) vuole ucciderle il cane. In un mondo gestito dalle macchine, invece, la tonalità tipica dei primi monitor a fosfori verdi viene percepita inconsapevolmente, diventando un elemento sostanziale per definire il luogo e il tempo dell’azione.
Il colore di per sé non è stato quella rivoluzione epocale che il marketing ha tentato di venderci, né il suo utilizzo ha reso i film migliori o peggiori. Ma un suo uso sapiente può toccare e mutare profondamente la percezione della storia e dei personaggi da parte del pubblico, in maniera delicata e spesso impercettibile.