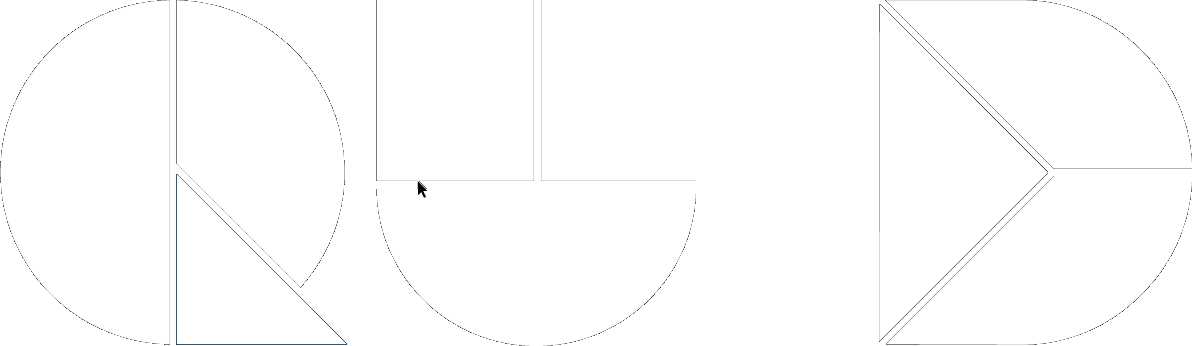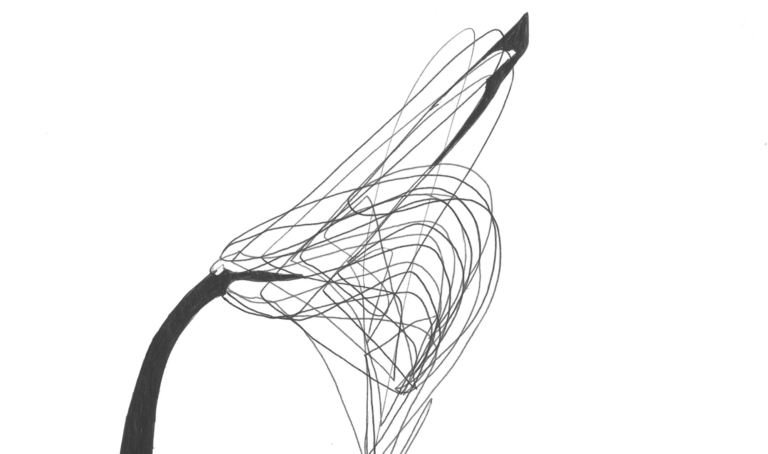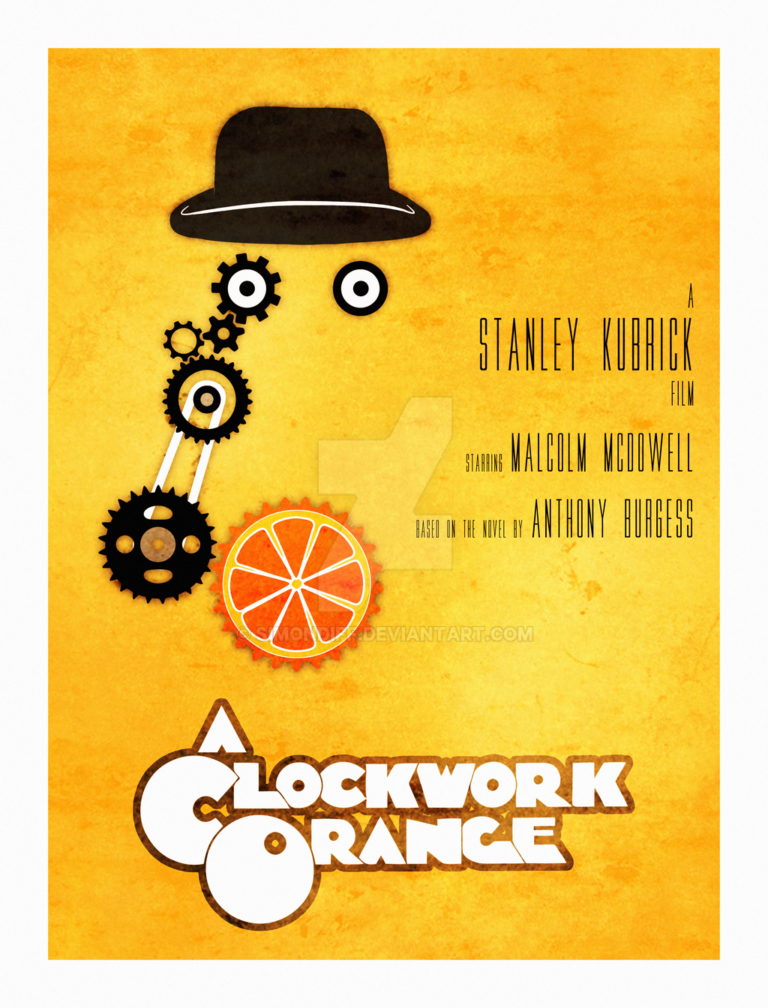Come studiare i residui di sparo usando ascensori, colori e meccanica quantistica
Quando la luce del sole colpisce il lampadario della nonna, e proietta una banda colorata sulla parete, il bambino che è dentro di noi esclama: arcobaleno! Così non fu per Newton il quale, notando che un prisma di vetro è in grado di separare la luce bianca in “sette” colori, pensò all’apparizione di un fantasma e chiamò quell’oggetto fisico “spettro”. Oggi nella terminologia scientifica contiamo lo spettro visibile, la spettroscopia o lo spettro infrarosso, e non colleghiamo più queste locuzioni al soprannaturale. Ma quel “fantasma” colorato, secoli dopo Newton, avrebbe aiutato i fisici a comprendere la struttura atomica.
Lyman, Balmer, Paschen, Brackett e Pfund forse non sono gli scienziati più famosi della storia, ma le loro ricerche hanno consentito di spiegare cosa accade quando le “particelle di luce” (fotoni) colpiscono una struttura atomica. Iniziamo dal caso più semplice: l’atomo di idrogeno, che qualcuno immagina come un piccolo sistema solare con il nucleo al centro (composto da un protone), e uno o più elettroni che vi orbitano attorno. Nella realtà questa metafora non funziona per niente, innanzitutto a causa di una differenza sostanziale. Gli oggetti macroscopici, come un sasso o la stazione spaziale internazionale (ISS), si possono mettere in orbita attorno alla terra a qualunque distanza, avvicinarsi di qualche centimetro o allontanarsi di un decimo di millimetro, senza problemi.
Gli elettroni invece si possono sistemare attorno a un nucleo solo ad alcune “altezze” specifiche. È per questo che la nuova Meccanica, che ha sconvolto il mondo all’inizio del XX secolo, si chiama Quantistica, perché la stabilità dei sistemi microscopici si ottiene solo per determinate “quantità” di energia, dette appunto “quantizzate”.
È un po’ come se l’elettrone “vivesse” in un palazzo, e sappiamo che le persone abitano al settimo piano, oppure all’ottavo; nessuno vive al “settimo piano e mezzo” (a parte forse la mente di John Malkovich, cit.). Gli elettroni quindi non si possono “mettere dove vogliono”, ma devono scegliere un certo “piano” del loro palazzo, ed eventualmente spostarsi su un altro piano.
Il grattacielo in cui vivono gli elettroni possiede poi un’altra particolarità. Nei palazzi normali la distanza verticale fra un piano e l’altro è più o meno costante, diciamo tre metri. Perciò se mi sposto dal primo al secondo piano, o dal terzo al quarto, salgo comunque di tre metri. Di conseguenza l’ascensore che utilizzo, per vincere la forza di gravità e guadagnare energia potenziale gravitazionale, si servirà della stessa quantità di energia elettrica ogni volta che salgo di un piano. Questo particolare “palazzo dell’idrogeno” invece è costruito in modo tale che ogni piano abbia un’altezza diversa e perciò, quando l’ascensore si muove da un piano all’altro, mi serve ogni volta una quantità di energia diversa. Questo vuol dire che uno scienziato (ma anche un investigatore della polizia molto curioso) potrebbe dedurre, con un procedimento inverso, solo guardando quanta energia elettrica è stata consumata dall’ascensore, il movimento esatto che questo ha compiuto: se è andato dal 5° piano al 6°, oppure dal 2° al 3°.
Infatti nell’atomo di idrogeno, se un elettrone abita ai piani bassi e vuole salire all’attico, ha bisogno di un “ascensore”, o meglio dell’energia che muova questo “ascensore”. E questa energia arriva proprio dalla luce. Ma siccome gli elettroni, come le persone, non possono abitare al 7° piano e ½, si spostano solo se arriva un fotone che ha esattamente l’energia richiesta per quella salita in ascensore. Se ne ha di meno, è come se l’elettrone arrivasse “quasi al piano”, ma senza riuscire a “scendere”, e quindi tornasse da dove è partito. Se ne ha di più, l’elettrone è come se “arrivasse lungo”, mancando il piano. In entrambi questi casi l’elettrone resta dov’era e la luce attraversa indenne gli atomi di idrogeno. Se invece l’energia è quella giusta, l’elettrone sale al piano superiore e il fotone “sparisce”, assorbito dall’elettrone sotto forma di energia utilizzata per la “salita” e trasformata in un’energia potenziale (non più gravitazionale ma elettromagnetica).
Questo fu quello che scoprirono quei primi fisici che si interessarono dell’interazione fra luce e materia: se illumino con un fascio di luce bianca un bulbo pieno di idrogeno, dall’altra parte arriveranno fotoni di tutte le energie, tranne alcune. I fotoni di quelle specifiche energie che consentono agli elettroni di fare i loro specifici “salti quantici” verso l’alto, dopo essere stati sparati dentro al gas di idrogeno, non ne fuoriescono più. Sono stati assorbiti. Ma l’energia di un fotone è quella che ne determina il colore. In modo spannometrico potremmo dire: tanta energia, violetto o blu – media energia, verde o giallo – poca energia, arancione o rosso. Ma chi è daltonico non tema: l’energia è legata al colore da numeri ben precisi (in particolare dalla frequenza dei fotoni). Perciò gli scienziati hanno potuto dedurre le energie quantiche solo guardando quali colori, sostituiti da righe nere, mancavano dagli “spettri di assorbimento”, (o meglio, misurando le relative frequenze).
Può anche accadere il contrario. Se prendo un bulbo pieno di gas di idrogeno in stato di quiete, non ne fuoriesce alcuna luce. Ma se trovo il modo di eccitarlo, e poi di stimolarlo, le cose cambiano. Eccitare e stimolare può essere spiegato con un’altra metafora: immaginiamo di mettere un pallone da calcio in cima al Monte Bianco (eccitare) e di aspettare un leggero venticello (stimolare): di sicuro il pallone cadrà a valle. Allo stesso modo gli elettroni che abbiamo eccitato “ai piani alti” cadranno verso il basso (usando sempre il nostro immaginario ascensore), rilasciando quindi energia sotto forma di un fotone, cioè luce. E di nuovo, poiché i salti quantici sono discreti e specifici, le energie dei fotoni espulsi sono ben determinate, dando luogo a uno “spettro di emissione” discreto: si vedono solo alcune righe di specifici colori, relativi alle specifiche frequenze dei fotoni emessi, e perciò alle loro specifiche energie.
La questione è molto più complessa di così. In primo luogo le emissioni non avvengono tutte nello spettro visibile, ma i fotoni di diversa energia possono ricadere in quelle bande che noi umani chiamiamo raggi X, ultravioletto, raggi gamma, infrarossi, etc. Inoltre quando mettiamo nel bulbo non più idrogeno ma elio, ferro o plutonio, le cose diventano via via più intricate: i nuclei atomici diventano ingombranti e interagiscono con una nube elettronica affollata che si sposta fra livelli quantistici sempre più numerosi. Ma questa situazione, lungi dall’essere irrisolvibile, diventa un’opportunità.
Immaginiamo una città costellata di grattacieli. Alcuni sono come quello che abbiamo già visto (i palazzi idrogeno), mentre altri sono “palazzi alluminio”, “palazzi bismuto”, “palazzi uranio” e così via. In ognuno di questi edifici gli ascensori si muovono fra piani di altezze diverse, come nel caso dell’idrogeno. E sebbene tutti i palazzi alluminio o uranio siano uguali fra loro, l’altezza dei loro piani è diversa rispetto a quella di ogni piano di qualunque altro “palazzo elemento”. Uno scienziato appollaiato sulla collina fuori città, solamente studiando l’assorbimento di energia elettrica richiesto dal nostro “ascensore”, potrebbe stabilire in maniera esatta il piano di partenza e quello di arrivo dello specifico tipo di palazzo e quindi potrebbe giungere alla conclusione certa che in quella città si trova almeno un palazzo (ad esempio) piombo.
Questo è il modo in cui fisici e chimici, ma anche studiosi di opere d’arte e periti balistici, analizzano i reperti: raccolgono i fotoni che lo attraversano (o che ci rimbalzano contro o dal quale vengono emessi o assorbiti) e ne guardano il “colore”; riescono così a dedurre quali elementi chimici siano presenti nel reperto stesso. Quando si fa fuoco con un’arma, ad esempio, i gas incandescenti in espansione spargono nell’ambiente un gran numero di particelle microscopiche dette residui di sparo (o GunShot Residue – GSR). Queste si formano nei momenti più caldi del fenomeno esplosivo a seguito di eventi termodinamici che coinvolgono i metalli contenuti nella miscela innescante, elementi chimici che difficilmente si combinano altrove in modo così peculiare sia per composizione che per morfologia. Il perito balistico perciò, per stabilire se le particelle rinvenute siano residui di uno sparo o siano invece frutto di una lavorazione meccanica o di fuochi d’artificio, deve innanzitutto raccogliere le particelle dalle mani del sospettato (o dagli abiti, dalla vettura e via dicendo) con un biadesivo montato su un tampone, detto Stub. Poi deve studiarne la morfologia con un microscopio elettronico a scansione (SEM). Infine deve analizzare tramite una sonda (EDX) i fotoni (nello spettro dei raggi X) emessi dalle particelle rinvenute, per stabilire col “metodo degli ascensori” da quali elementi siano composte. Solo allora potrà iniziare la sua attività di perizia, che prevede però ancora molti passaggi, per arrivare forse a sostenere che quei residui provengono in maniera univoca da un evento di sparo.
Quanta strada abbiamo percorso, da quando subivamo il fascino ipnotico dei piccoli arcobaleni, proiettati sulle pareti di casa dal lampadario di nonna…