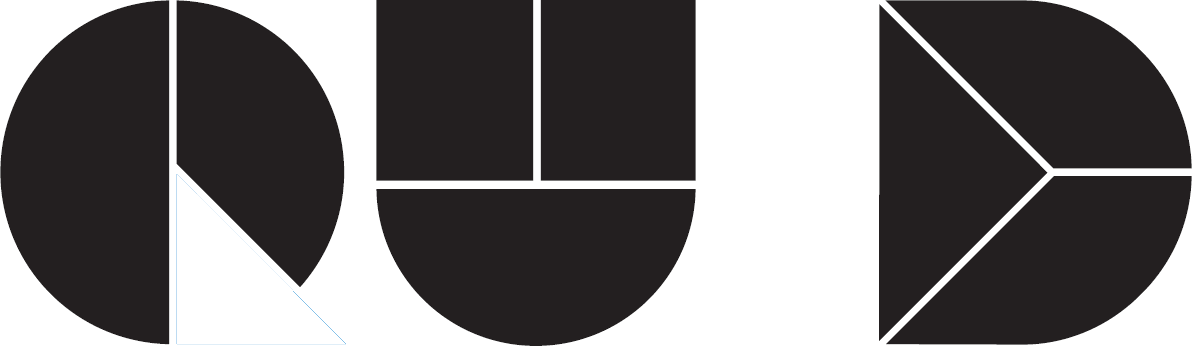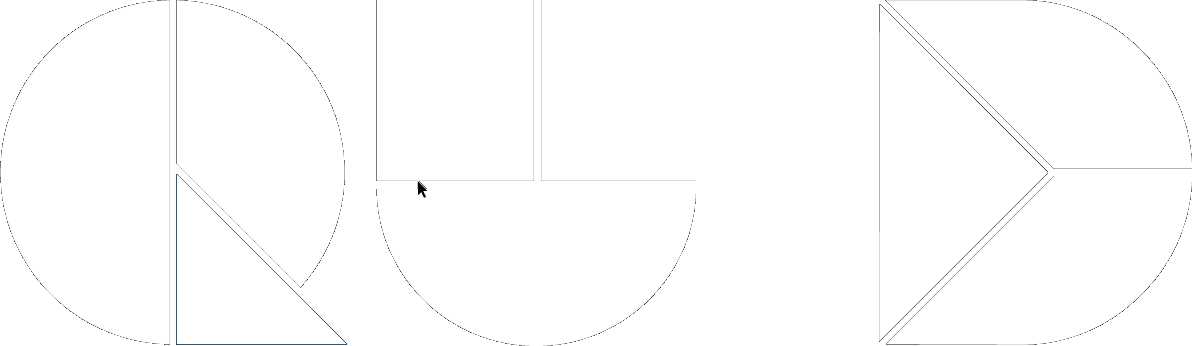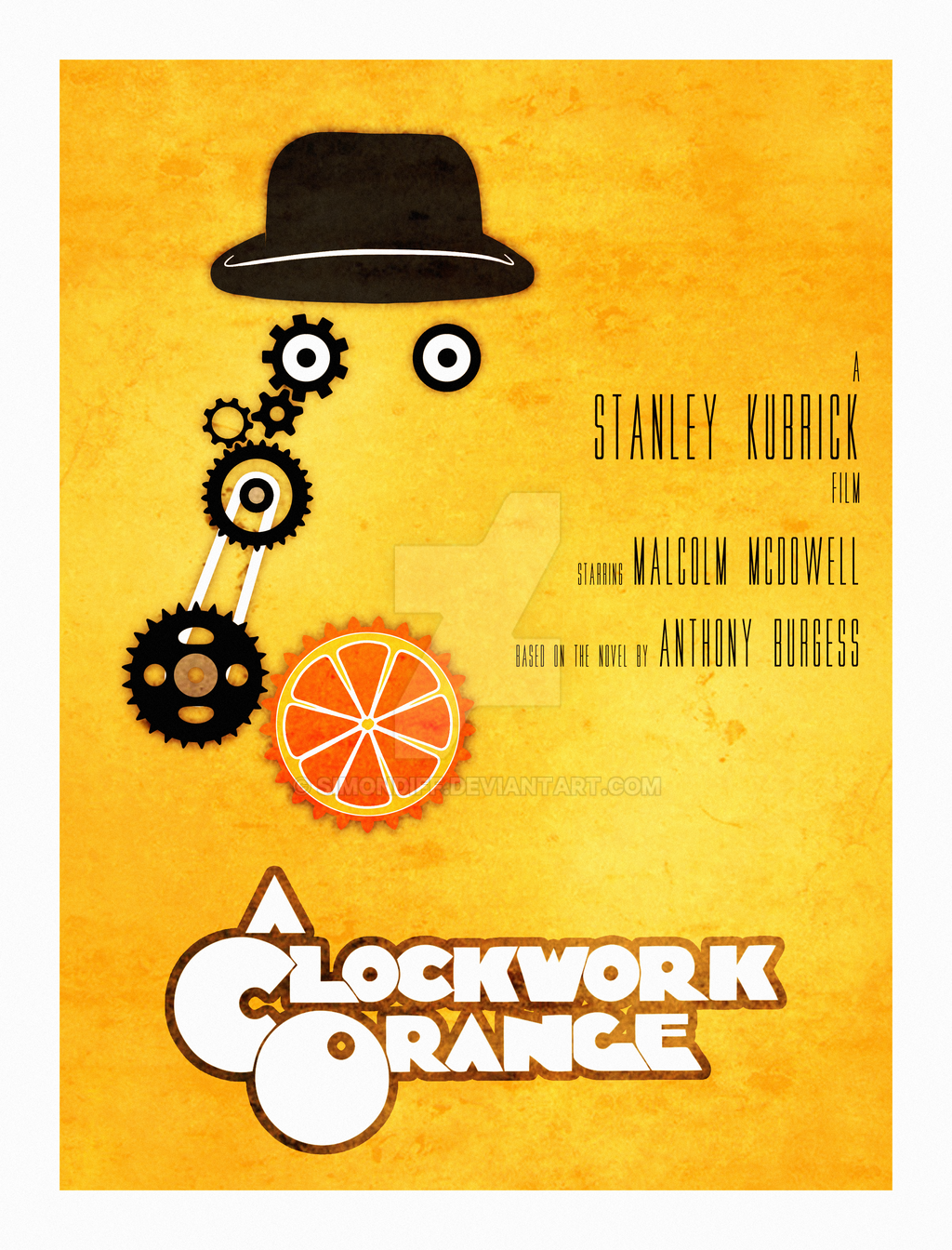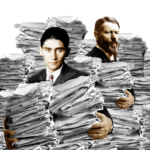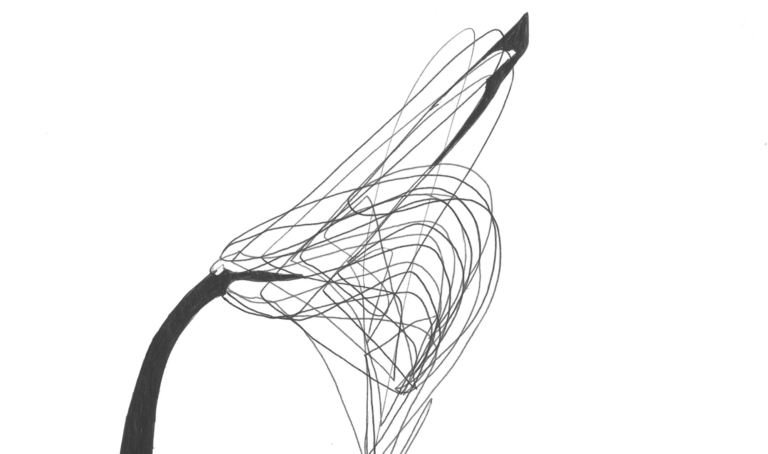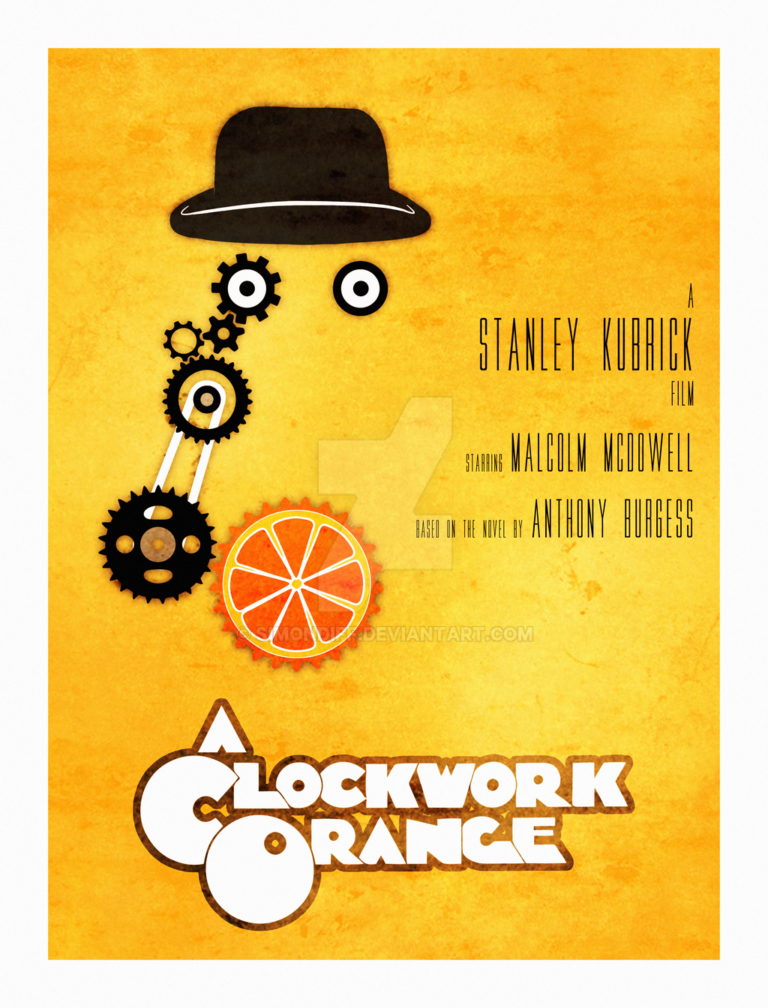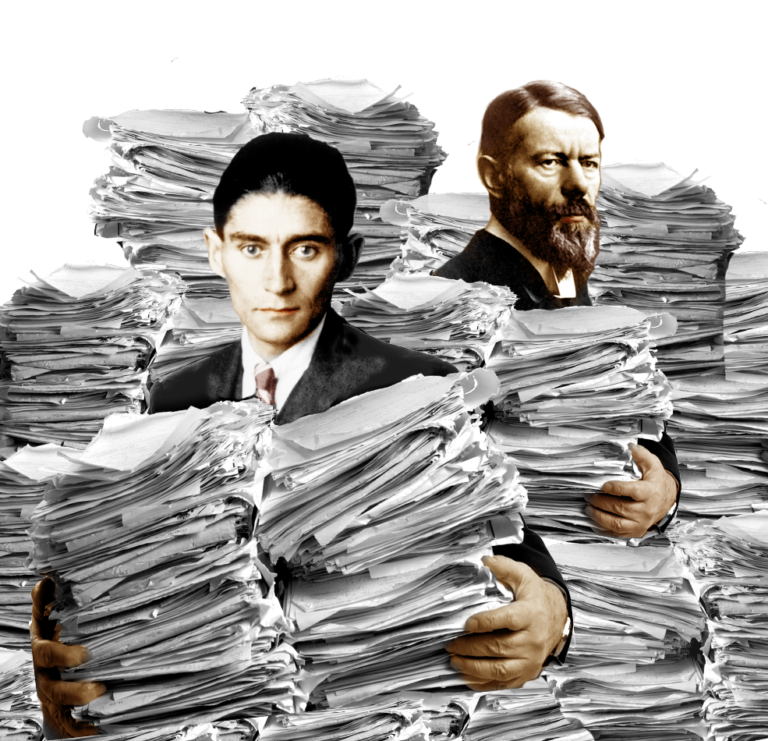La lingua come identità: dal Nadsat di Burgess alle lingue artificiali nel cinema
Se i tuoi glazzi riescono a viddare le prime slove di questo govorietto, di sicuro il tuo gulliver è pien di interessy bolsci che raramente diventano horrorshow nella gita quotidiana. Sarei tentato di continuare così per tutto l’articolo ma temo di scatenare nel lettore gli stessi “interessi bolsci” che aveva Alexander “Alex” DeLarge. Il “Nadsat” è il gergo inventato da Anthony Burgess per il romanzo “Arancia Meccanica” (1962), poi reso celebre dall’adattamento cinematografico di Stanley Kubrick (1971). Il termine stesso “Nadsat” deriva dal suffisso russo “-надцать” (-nadtsat), che significa “-teen” in inglese, e si rifà quindi al linguaggio degli adolescenti. Ma perché inventare un argot o addirittura una lingua intera? Oltre alla più ovvia delle risposte, ovvero dare più valore alla narrazione (immaginate gli elfi de “Il Signore degli Anelli” senza il loro affascinate idioma), forse il motivo più valido lo troviamo in un libro del 1948 che ha trasceso il suo status di romanzo per diventare un punto di riferimento culturale e politico globale: 1984.
Nel capolavoro distopico di George Orwell, la “neolingua” (Newspeak) non è solo un espediente narrativo ma uno strumento di controllo: “La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza”. Questi slogan illustrano come il linguaggio possa diventare arma per manipolare la realtà percepita. Non diversamente da HAL 9000 in “2001: Odissea nello spazio”, che usa il linguaggio per mascherare le proprie intenzioni letali, la neolingua orwelliana ha lo scopo di rendere impossibile persino concepire pensieri sovversivi.

La trasposizione cinematografica di queste lingue artificiali rappresenta una delle sfide più affascinanti per i registi. Nell’adattare “Arancia Meccanica”, Kubrick si trovò di fronte al problema di rendere sullo schermo quel gergo così particolare che pervade il romanzo. Optò per una strategia intelligente: anziché sommergere lo spettatore con il Nadsat nella sua forma più pura (come fa il libro), ne dosò l’uso, enfatizzando termini chiave come “ultraviolenza”, “droog” e “moloko plus”. Questo approccio permise al pubblico di entrare gradualmente nel mondo linguistico di Alex, mentre l’effetto di straniamento veniva affidato principalmente agli elementi visivi – l’arredamento futuristico, i costumi bizzarri, l’uso del grandangolo che distorce le proporzioni.
Il linguaggio del cinema, già di per sé una forma di comunicazione con regole e codici propri, si arricchisce e si complica quando deve rappresentare lingue inventate. Si pensi al tlhIngan Hol, la lingua parlata dai Klingon di “Star Trek”, creata dal linguista Marc Okrand con una struttura grammaticale, fonologica e sintattica completa. Da semplice espediente per caratterizzare una razza aliena è diventato un fenomeno culturale con dizionari pubblicati (con tanto di codice ISO 639-2:tlh), opere letterarie tradotte (incluso l’”Amleto” di Shakespeare) e migliaia di appassionati che lo studiano e lo parlano.
Il cinema fantascientifico ha fatto della creazione linguistica una delle sue cifre stilistiche. Nel film “Arrival” (2016) di Denis Villeneuve, tratto dal racconto “Storia della tua vita” di Ted Chiang, il linguaggio alieno diventa il tema centrale della narrazione. La protagonista, una linguista incaricata di comunicare con visitatori extraterrestri, scopre che il loro modo di esprimersi non lineare modifica la percezione stessa del tempo. Qui la lingua diventa molto più di un mezzo comunicativo: è una finestra su una diversa concezione della realtà.
James Cameron, assieme a molti altri registi, ha investito risorse significative nella creazione di linguaggi credibili per i mondi di finzione. Per “Avatar” (2009), il linguista Paul Frommer ha sviluppato il Na’vi, con circa 1000 vocaboli e una grammatica complessa, pensata per essere pronunciabile dagli attori umani pur mantenendo un “sound” alieno. Questo livello di dettaglio contribuisce all’immersione dello spettatore in un mondo completamente diverso dal nostro.

Ma torniamo a Kubrick e alla sua ossessiva attenzione per i dettagli. La scelta di consultarsi con Marvin Minsky per il personaggio di HAL 9000 in “2001” riflette lo stesso approccio utilizzato per il Nadsat in “Arancia Meccanica”: nulla è lasciato al caso. Come ha dato credibilità all’intelligenza artificiale di HAL attraverso il linguaggio e il comportamento, così ha dato autenticità al mondo di Alex attraverso il suo peculiare modo di esprimersi. In entrambi i casi, il linguaggio diventa un personaggio a sé stante, capace di rivelare e nascondere, di sedurre e minacciare.
È interessante notare come Kubrick utilizzi spesso il linguaggio per creare un effetto di distanziamento emotivo. In “Arancia Meccanica” i termini Nadsat come “tolchock” (colpire) o “viddy” (vedere) attenuano l’impatto della violenza descritta mentre in “2001”, il tono monocorde e apparentemente ragionevole di HAL (“I’m sorry, Dave. I’m afraid I can’t do that”) rende ancora più inquietante il suo tradimento. Il regista comprende che il linguaggio non è mai neutrale, ma sempre un veicolo di potere e controllo.

Quest’utilizzo delle lingue artificiali nel cinema ha influenzato profondamente anche la televisione contemporanea. Showrunner di serie come “Game of Thrones” hanno affidato al linguista David J. Peterson lo sviluppo del Dothraki e dell’Alto Valyriano, lingue che oggi vantano comunità di appassionati e corsi online. Non più semplici orpelli esotici, queste creazioni linguistiche sono diventate elementi fondamentali per la worldbuilding e lo storytelling moderno.
E cosa dire del recente tentativo di Christopher Nolan in “Oppenheimer” (2023) di rendere visivamente e acusticamente la complessità del linguaggio della fisica quantistica? Anche qui assistiamo a un uso del gergo specialistico come strumento per creare un effetto di straniamento nel pubblico, per separare il mondo di Oppenheimer da quello comune e renderlo, paradossalmente, più autentico nella sua inaccessibilità.
Così da Burgess a Kubrick, da Cameron a Villeneuve, il cinema continua a esplorare il potere delle lingue inventate per creare mondi alternativi, per esaminare il rapporto tra linguaggio e percezione, e per ricordarci che le parole non solo descrivono la realtà, ma contribuiscono attivamente a plasmarla.
Come Alex in “Arancia Meccanica”, che gradualmente è forzato ad abbandonare il Nadsat, anche noi spettatori usciamo da queste esperienze cinematografiche con una rinnovata consapevolezza: il linguaggio, sia esso inventato o reale, è molto più di un mezzo comunicativo. È uno strumento di potere, un’arma di seduzione, un veicolo d’identità che, inquadrato dalla macchina da presa, diventa parte integrante della grammatica stessa del cinema.
E forse, in un’epoca in cui anche le intelligenze artificiali stanno sviluppando i propri linguaggi specializzati, rivisitare questi esperimenti linguistici ci aiuta a comprendere meglio la complessità del rapporto tra parola e immagine, tra lingua e identità, tra finzione e realtà – rapporti che il cinema, meglio di qualsiasi altra arte, sa esplorare nelle sue infinite sfaccettature.