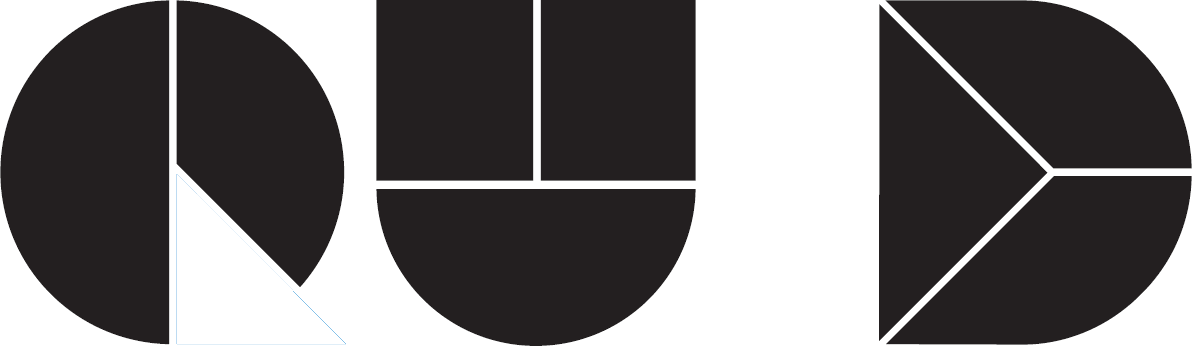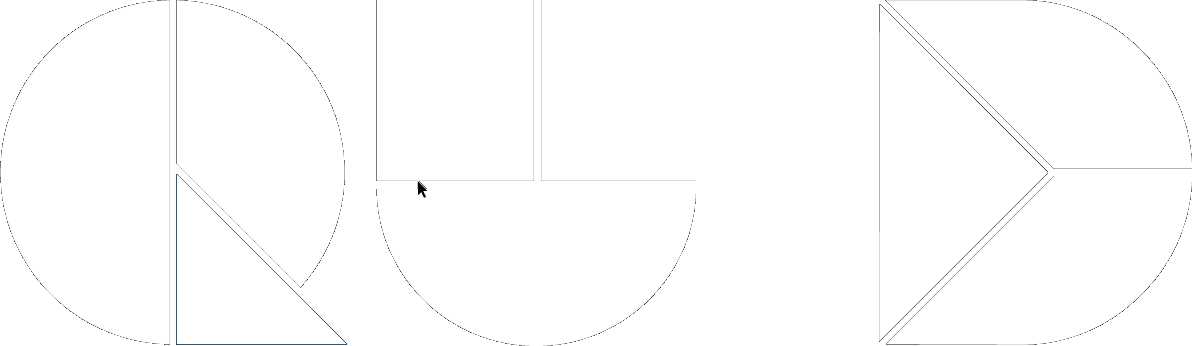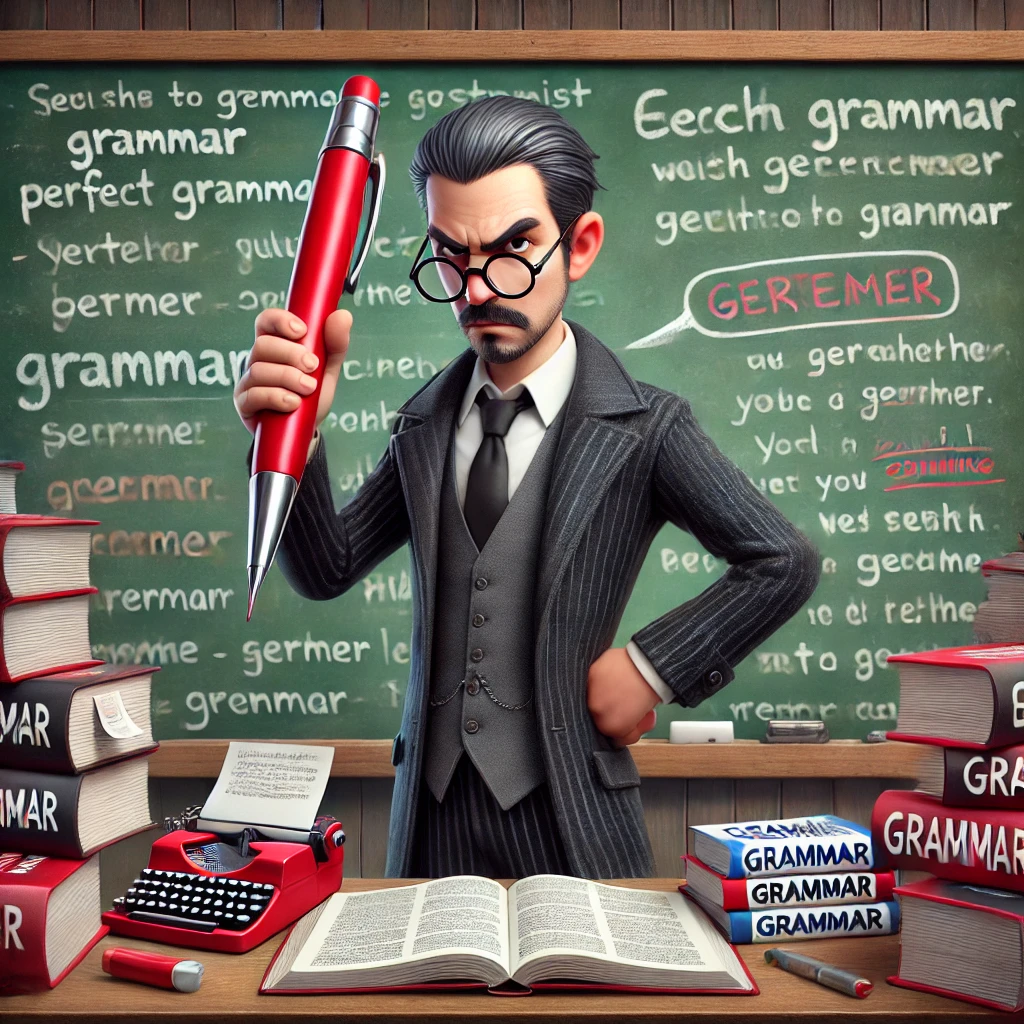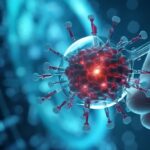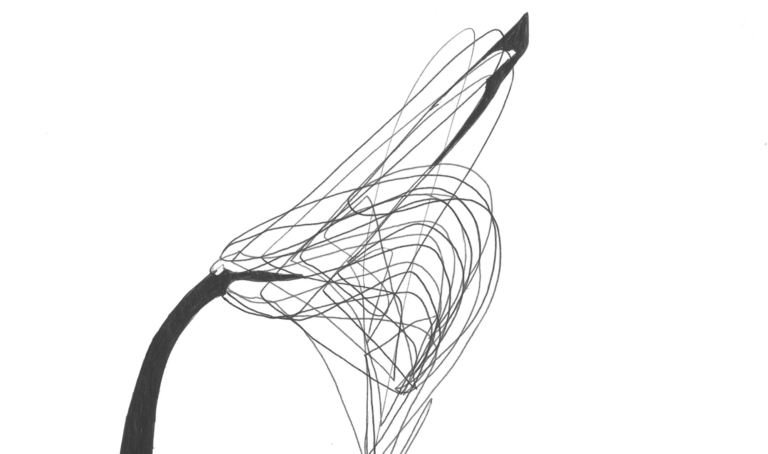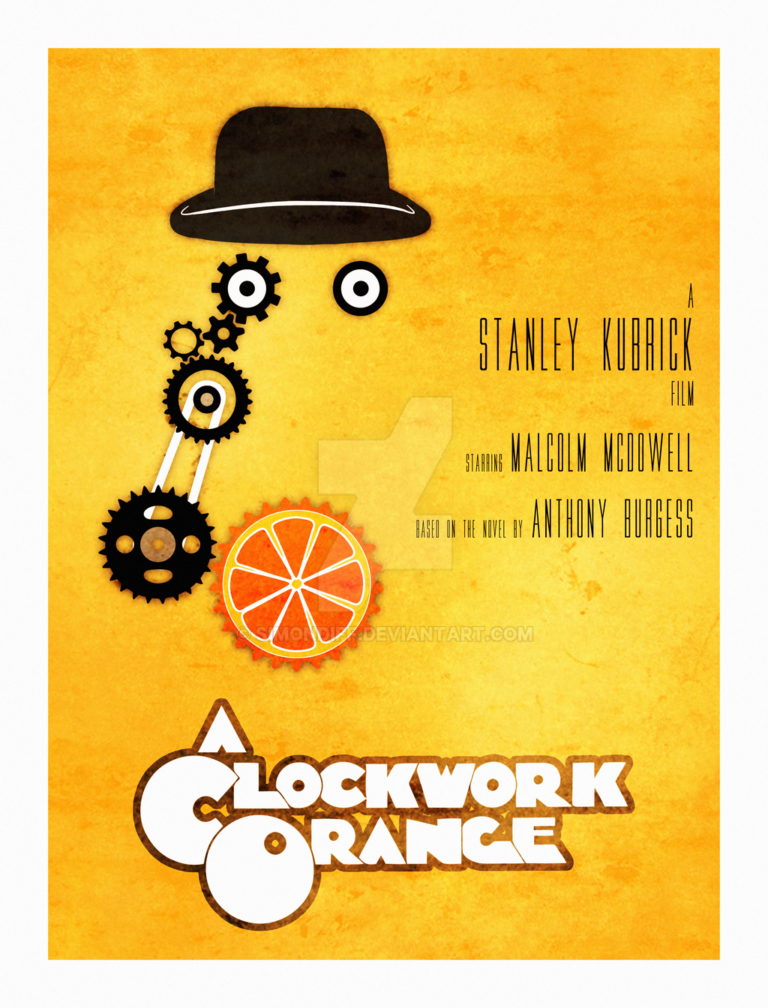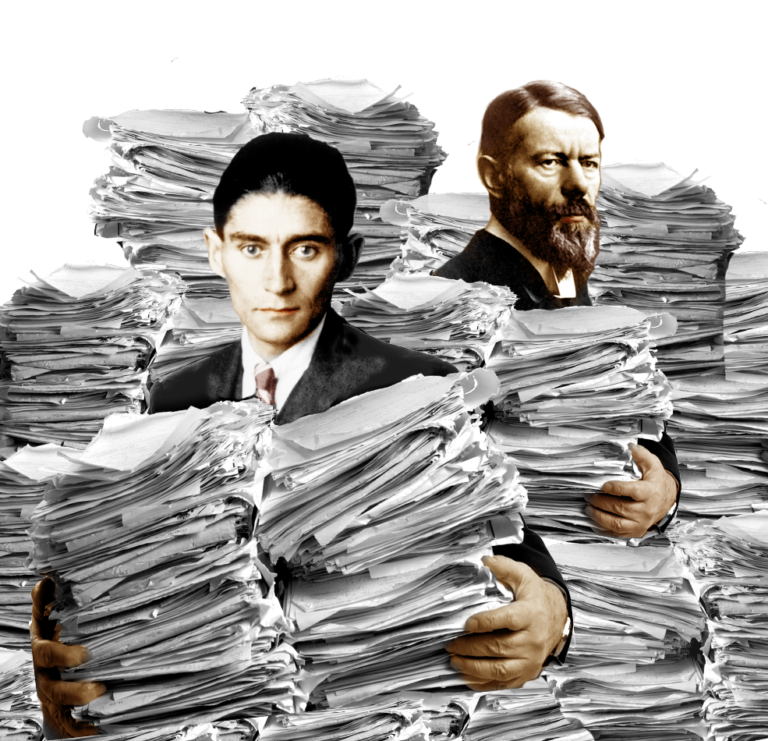Psicologia dei grammar-nazi
«L’errore mostra una mancanza di rispetto nei confronti dell’altro; perché mai dovrei rallentare e cercare di capire cosa stai dicendo?».
«[…] essere professionali significa anche imparare a comunicare in maniera efficace. Ogni errore in grado di distrarre dal messaggio ne riduce l’efficacia».
«Sono disposto a perdonare gli errori dovuti a una digitazione veloce nella comunicazione via e-mail, ma non all’interno di documenti, presentazioni o contratti. Mi ritengo altamente critico nei confronti di chi usa le parole in modo scorretto […]. Mi fa pensare che la persona non sia intelligente».
Tratto dalle risposte di alcuni partecipanti alla ricerca di Gubala, Larson & Melonçon (2000)
C’è chi darebbe del “grammar-nazi” ad alcuni dei partecipanti allo studio Do writing errors bother professionals?, finalizzata a studiare il fenomeno degli errori di scrittura e la loro percezione. Diventata ormai d’uso comune sui social, quella dei grammar-nazi è un’etichetta nata per indicare coloro che si ritrovano a correggere gli errori linguistici altrui, spesso con un atteggiamento di critica o pedanteria. Ma cosa spinge un grammar-nazi a mettere in atto questo comportamento? Le motivazioni potrebbero essere svariate e andare ben oltre il semplice amore per la lingua.
Un mondo caotico. Una forte attenzione al dettaglio sembrerebbe essere la prima, lampante peculiarità che caratterizza il grammar-nazi, al punto da indurlo a focalizzarsi più sulla forma del messaggio che sul contenuto. Tale atteggiamento suggerisce in alcuni casi un bisogno di controllo: in un mondo percepito come caotico o deviante rispetto alle regole, la grammatica diventa un’isola di certezze, e correggere gli errori altrui una strategia per restituirgli illusoriamente ordine. A tal proposito, uno studio condotto da Boland e Queen (2016) ha mostrato come soggetti con elevati livelli di diligenza e scrupolosità (un tratto caratteriale noto come coscienziosità) risultino essere maggiormente infastidite dagli errori di battitura rispetto a coloro che presentano bassi livelli di tale tratto.
Un mondo ingiusto. C’è di più, però, rispetto alla necessità di ordine e controllo. La tendenza all’ossessività tipica del grammar-nazi, infatti, non sembrerebbe spiegare del tutto l’irritabilità che talvolta ne caratterizza i commenti. Potrebbe risultare interessante, allora, avvalersi del concetto di “doverizzazione”, un bias cognitivo caratterizzato da regole assolute, inflessibili e irrealistiche su come dovrebbe funzionare il mondo. Nel caso in questione, in un mondo giusto ognuno dovrebbe padroneggiare quantomeno la propria lingua madre e ricordarsi di accendere il cervello quando scrive (doverizzazione di correttezza). Quando le doverizzazioni si scontrano con la realtà dei fatti, le reazioni tipiche sono di rabbia: un tentativo di difendere con forza l’idea di mondo a cui ci si è aggrappati. Una ricerca sul tema (Wolfe, Shanmugaraj & Sipe, 2016) approfondisce la questione, mostrando come le persone siano più propense a perdonare un errore grammaticale quando a conoscenza del fatto che lo scrivente è uno straniero; per i madrelingua, tuttavia, non sembrerebbero esserci scuse. A parità di errore, lo stesso può essere vissuto dunque come trascurabile o profondamente irritante, a seconda di come pensiamo debba funzionare il mondo.
Un mondo da quattro soldi. Una terza spiegazione del comportamento dei grammar-nazi chiamerebbe in causa il narcisismo come tratto di personalità: chi corregge gli errori altrui potrebbe essere costantemente impegnato nel tentativo di mantenere un’immagine di sé positiva, attraverso la svalutazione dello scrivente. Il meccanismo, per quanto inconscio, è semplice: se è l’altro a sbagliare, sarò necessariamente io quello di valore, secondo un tentativo di compensazione temporanea e disfunzionale dell’autostima. Colui che si avvale di tali meccanismi potrebbe inoltre vedere nella correzione dell’altro un’opportunità per esibire il proprio sapere e affermare una superiorità intellettuale, alimentando ulteriormente il proprio ego. Nello studio citato di Boland & Queen (ibidem) emerge infatti come soggetti con bassi livelli di “gradevolezza”, un tratto caratteriale legato al mostrarsi amichevoli e cordiali (e dunque scarsamente svalutanti nei confronti dell’altro), tendono ad essere maggiormente infastiditi dagli errori grammaticali.
Regolazione emotiva, ansia sociale e leoni da tastiera. Sia chiaro: quello dei grammar-nazi non è di certo tra i fenomeni più studiati nella letteratura psicologica, e non rappresenta nemmeno un’etichetta clinica o diagnostica (il termine, qui adoperato per descrivere un fenomeno sociale così com’è noto ai più, è anzi denigratorio nell’associare a una necessità umana gli estremismi di un avvenimento storico); pertanto, quelle discusse rappresentano solo alcune tra le ipotesi potenzialmente in grado di spiegare il comportamento di chi corregge, ipotesi indubbiamente parziali e – soprattutto – da sottoporre a validazione empirica. Il fenomeno potrebbe essere infatti più complesso e da ricondurre a una molteplicità di spiegazioni. Un buon candidato è rappresentato dall’incapacità di regolare le proprie emozioni: gli errori potrebbero essere intrinsecamente fastidiosi per la maggioranza dei lettori, ma una scarsa regolazione emotiva potrebbe rendere il correttore incapace di inibire il fastidio dinanzi a qualcosa di imperfetto. Altri utili concetti esplicativi potrebbero includere quelli di autocritica e proiezione. Chi tende ad essere fortemente critico verso di sé potrebbe ritrovarsi, attraverso un meccanismo di difesa, a proiettare sull’altro il proprio severo giudizio interiore; bacchettare l’altro si configura allora come una difesa contro le proprie insicurezze, un modo per deviare l’attenzione dal proprio senso d’inadeguatezza. Un ultimo aspetto d’interesse è la tendenza dei grammar-nazi a manifestare il loro comportamento principalmente online. Le correzioni sembrano avvenire più frequentemente nel mondo virtuale, dove si ha l’illusione di essere protetti da una certa distanza. Tale comportamento è da ricondursi a un’altra categoria di persone comunemente nota come “leoni da tastiera”, vale a dire coloro che adottano online comportamenti che non manifesterebbero nella vita reale. La correzione dell’errore diventa in questi casi una forma di espressione di sé scevra dai rischi di un confronto diretto.
Cosa dice la scienza. Quale che sia la motivazione di fondo, una cosa è certa: il modo in cui reagiamo agli errori grammaticali riflette profondamente la nostra personalità e il nostro rapporto con l’ambiente circostante, o forse, nella stessa misura, il rapporto che abbiamo con noi stessi.
Nella tabella, una panoramica dei più interessanti risultati scientifici sul fenomeno.
FONTE | RISULTATI |
Gubala, Larson & Melonçon (2000) | · L’irritazione causata dagli errori grammaticali è cresciuta rispetto agli studi precedenti. · I lettori più giovani risultano essere meno irritati dall’errore rispetto a quelli più anziani. · I lettori tendevano a descrivere lo scrittore in errore come negligente o frettoloso. |
Wolfe, Shanmugaraj & Sipe (2016) | · Gli errori dovuti al tono utilizzato o che denotano mancanza di educazione risultano essere maggiormente sgraditi rispetto a quelli grammaticali. |
Boland & Queen (2016) | · I grammar-nazi non differiscono per livello d’istruzione rispetto ai non-grammar-nazi. · Le persone estroverse tendono a trascurare gli errori e a giudicare meno severamente chi li commette, mentre i soggetti più introversi possono formarsi un’opinione più negativa di chi li commette. · Coloro che presentano livelli più bassi del tratto di personalità noto come “gradevolezza” risultano essere infastidite dagli errori grammaticali, mentre le persone con elevati livelli di coscienziosità e con bassi livelli di apertura mentale notano più facilmente gli errori di battitura. |
Appelman & Schmierbach, (2017) | · Gli articoli presenti nei notiziari, se caratterizzati da un numero relativamente ampio di errori, sono percepiti come meno credibili e informativi. |
Shore, Tashchian & Forrester (2020) | I candidati il cui CV presentava degli errori: · avevano meno probabilità di essere intervistati e assunti; · erano valutati come scarsamente in linea con la posizione offerta; · ricevevano offerte salariali meno allettanti. |