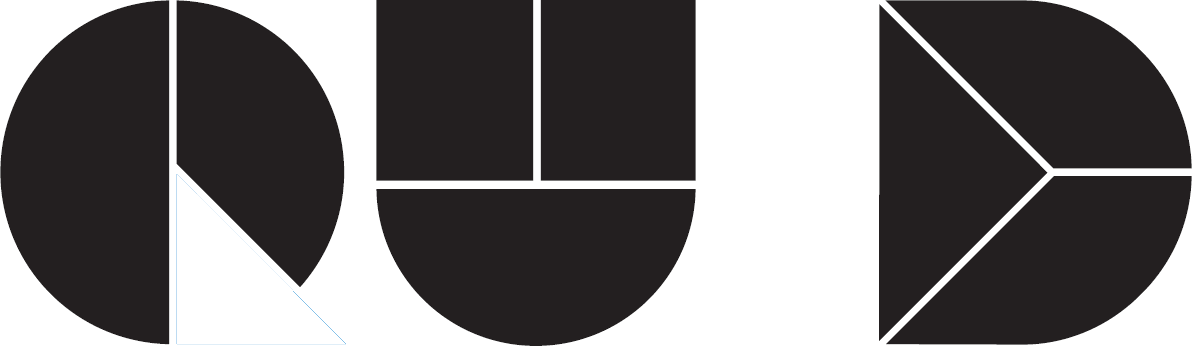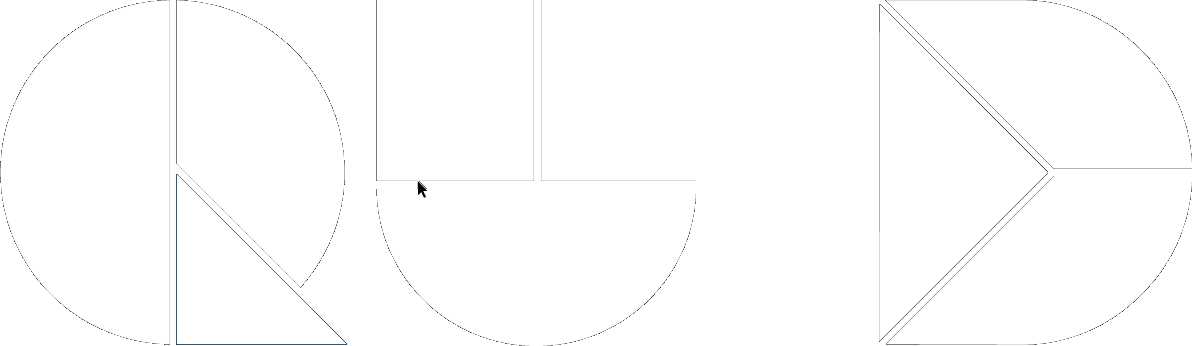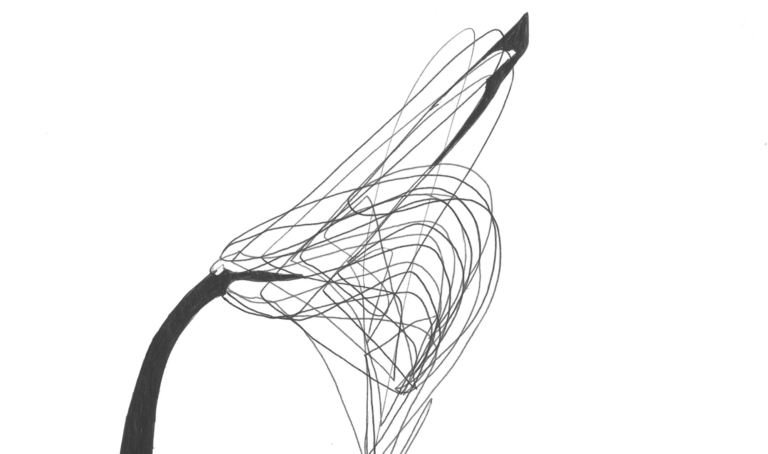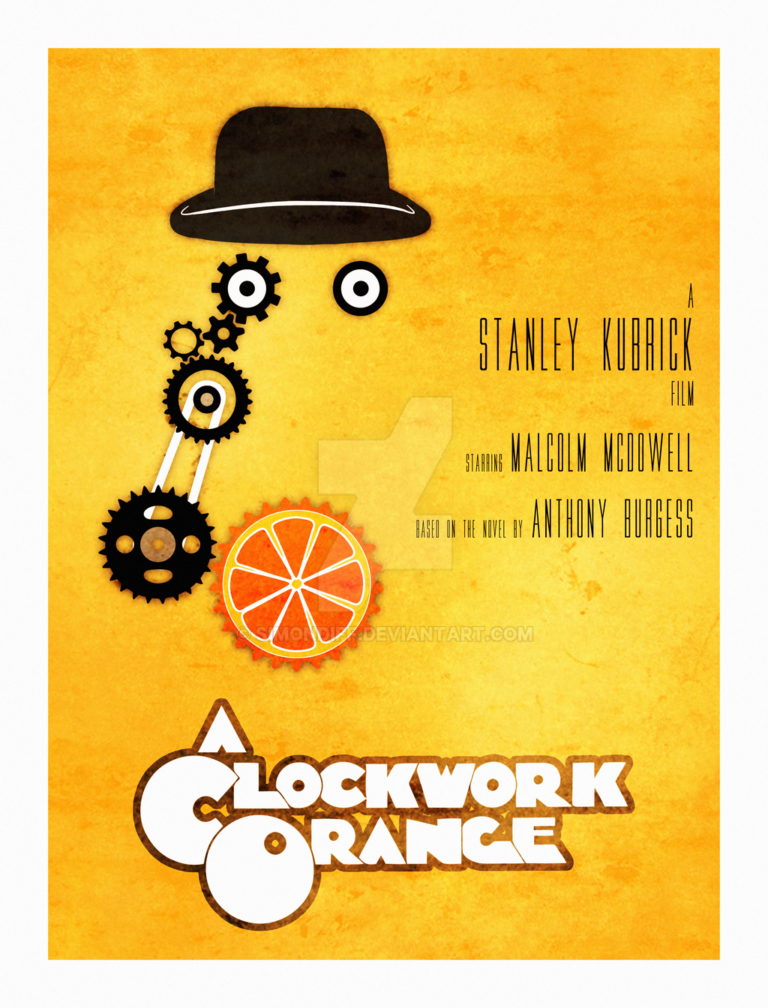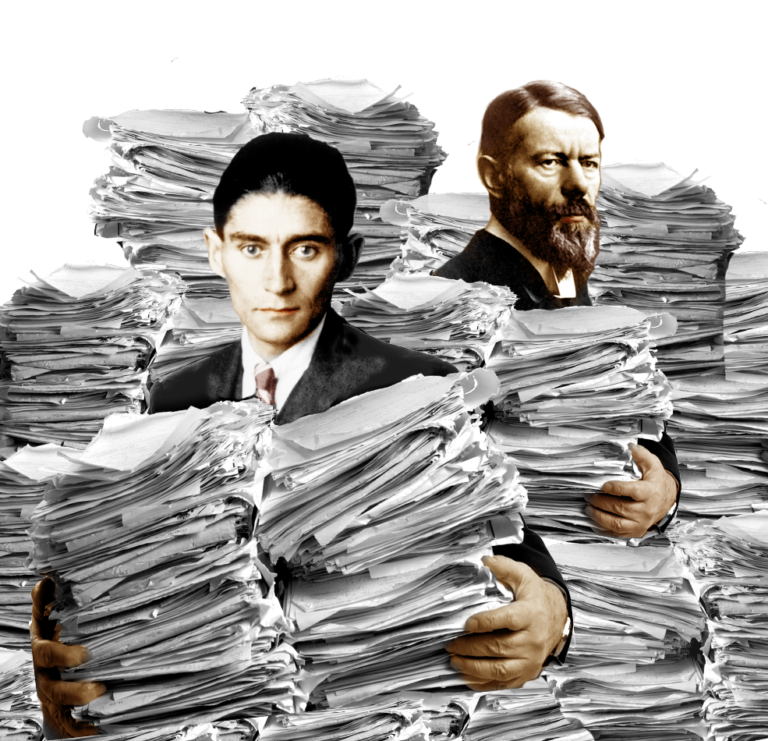Semiotica del linguaggio criminale
In campo criminologico si distinguono due tipi di aggressività: proattiva e reattiva, che si distinguono in base ai rispettivi obiettivi. Ognuno dei due tipi è associato a espressioni contrastanti, fattori suscitanti, percorsi neurali, sviluppo e funzione; e la distinzione è utile anche per comprendere la natura, l’evoluzione e il linguaggio della violenza umana.
L’aggressione proattiva comporta un attacco pianificato intenzionale per il raggiungimento di una ricompensa esterna o interna (bullismo, stalking, imboscate, omicidi premeditati, vendetta pianificata); al contrario l’aggressività reattiva è una risposta a una minaccia o a un evento sinistro, col solo fine di rimuovere lo stimolo provocante (difesa, lotte derivanti da insulti reciproci, crimini passionali subito dopo la scoperta dell’infedeltà).
L’aggressività proattiva è quindi predatoria, offensiva, controllata o fredda, con sforzi puramente premeditati e deliberati per danneggiare una particolare vittima, ed è spesso associata a mancanza di eccitazione emotiva. Allo stesso modo l’aggressività reattiva è impulsiva, affettiva, ostile, difensiva, emotiva o calda, con combattimenti non pianificati ricchi di eccitazione emotiva, spesso rabbiosa. È da notare che i termini “predatorio”, “affettivo” e “difensivo” sono più comuni in psichiatria mentre “premeditato” e “impulsivo” sono tipici nei sistemi giuridici.
Non sempre si distinguono le due entità: a volte si esprime un’aggressione proattiva e reattiva nello stesso atto, come quando un atto premeditato viene continuato con una difesa efficace e l’iniziatore è costretto a una lotta reattiva; altre volte i due tipi possono essere conseguenziali, ad esempio quando un individuo frustrato da un conflitto si arrabbia (reattivamente) e in seguito trama freddamente vendetta (proattivamente).

Il biologo Aron Tulogdi scoprì che nei ratti l’aggressività proattiva per l’alimentazione è associata alle aree neuroanatomiche amigdala centrale e basolaterale, ipotalamo laterale e grigio periacqueduttale ventrolaterale; invece, l’aggressività reattiva per la difesa è associata ad amigdala mediale, ipotalamo mediobasale e grigio periacqueduttale dorsale. Queste differenze di innervazione sono state poi riscontrate anche in altri mammiferi con notevoli somiglianze: la condivisione del disegno neuroanatomico suggerisce quindi che nell’uomo l’istinto aggressivo ha una filogenesi primatologica comune, si attiva quindi con un medesimo processo neurofisiologico e si esplica dunque con comportamenti, violenti o non, universali (Institute of Experimental Medicine, Budapest, Ungheria, 2010).
Ripercorrendo la linea evoluzionistica dell’Homo sapiens sapiens, il pioniere della primatologia comportamentale Richard W. Wrangham sostiene che gli scimpanzé esprimono aggressività proattiva sia contro i membri del suo gruppo, sia facendo attacchi a sorpresa alle comunità nelle aree di confine con armi rudimentali improprie (pietre, rami di albero…). E quando una colonia sconfigge l’altra, i vincitori saccheggiano la casa dei perdenti. La frequenza di questo comportamento varia a seconda di fattori come il numero di maschi nella comunità e la densità di popolazione, ma nel complesso si traduce in tassi di mortalità significativi, superiori a quelli riportati nell’aggressione intergruppo tra qualsiasi altro primate non umano, nella maggior parte dei quali tale comportamento è sconosciuto.
Nei bonobo non è stata osservata alcuna aggressione proattiva che porti a uccisioni intragruppo o intergruppo (Harvard University, Cambridge, USA, 2017).
Un tipo di violenza comune tra i gorilla invece è l’infanticidio, che rappresenta il 21% delle cause di mortalità dei cuccioli. Si ipotizza che sia una strategia riproduttiva: è nell’interesse del maschio, che ha preso il controllo di un gruppo di femmine, uccidere proattivamente la prole del maschio competitore precedente, eliminando ogni sua traccia genetica per poter rendere le femmine disponibili per lui. È interessante il risvolto, non comune all’essere umano: la femmina di gorilla si unisce di sua spontanea volontà all’aggressore dopo egli le ha sterminato la prole.
L’antropologo Craig Palmer teorizzò che l’aggressione più frequente nell’orango fosse lo stupro, anche se le motivazioni riguardo al suo finalismo rimangono ancora ipotetiche. La peculiarità risiede però nell’aggressore: un particolare tipo di maschio adulto bloccato in un corpo di adolescente, un’anomalia nel mondo delle grandi scimmie (University of Missouri, Columbia, USA, 1989).

Gli oranghi, gli scimpanzé e i gorilla sono tre specie in cui i maschi sono demoniaci. Malgrado la loro vita quotidiana sia tranquilla, i maschi adulti delle tre specie sono dei potenziali bruti, responsabili di occasionali atti di violenza che nella società umana sarebbero considerati crimini efferati.
Nel dualismo della violenza, gli esseri umani si sono evoluti combinando una bassa propensione all’aggressività reattiva, come nei bonobo, con un’alta propensione all’aggressività proattiva, come negli scimpanzé, anche se i maschi umani non sembrano affatto progettati per essere dei lottatori: sono piuttosto esili, hanno ossa leggere, non hanno canini sufficientemente affilati e non sembra abbiano armi naturali. Tuttavia, questa prima impressione inganna perché in realtà gli umani non infrangono le regole dell’aggressività: il progetto evolutivo ha permesso agli umani di combattere come i primati, ma in maniera diversa.
L’aggressione è guidata neurofisiologicamente dal sistema nervoso ortosimpatico: l’amigdala, infatti, percepisce la situazione di pericolo e avvia una trasmissione nervosa di risposta che coinvolge ipotalamo, adenoipofisi e surrene, che culmina con la secrezione di cortisolo e adrenalina nella circolazione sanguigna. Tali ormoni avviano nelle varie regioni anatomiche specifiche risposte con un denominatore comune, apportare energia e cambiamenti fisici e mentali al soggetto per prepararlo all’azione proattiva o reattiva: il muscolo dilatatore dell’iride si contrae garantendo la dilatazione della pupilla (midriasi), permettendo un maggior assorbimento di luce ed informazioni spaziali sul nemico; i bronchi si dilatano e la frequenza respiratoria aumenta (tachipnea), favorendo un maggior guadagno di ossigeno dall’ambiente; il battito cardiaco accelera (tachicardia), permettendo un rapido rilascio di ossigeno e sostanze nutritive ai tessuti; i vasi sanguigni degli organi interni (tranne cuore e polmone) e della cute si costringono, il sangue viene quindi canalizzato nei vasi sanguigni del cuore e dei muscoli scheletrici, che si dilateranno, favorendo un maggior guadagno di ossigeno e sostanze nutritive agli apparati dediti al combattimento. Senza tali cambiamenti l’uomo è del tutto inadeguato di fronte al pericolo.

Di contro, nella valutazione di un comportamento reattivo ma non aggressivo, dominato dalla paura, il linguaggio non verbale della vittima si palesa con: presenza di microespressioni facciali quali sopracciglio leggermente alzato, fronte tesa, bocca semiaperta, labbro inferiore arretrato; postura incurvata, rannicchiata, chiusa, con braccia incrociate per difendere gli organi vitali e rifugiarsi dal pericolo; sguardo evasivo reso da insicurezza, nervosismo, ansia, irrequietezza, oppure fisso sulla fonte del pericolo per non perdere di vista l’imminente minaccia; movimenti bruschi o maldestri, brevi, rapidi e irregolari o, paradossalmente, paralisi.
L’origine della violenza umana è un tema sul quale sono state erette teorie filosofiche divergenti: secondo Thomas Hobbes, l’essere umano è paragonabile a un animale feroce in lotta coi suoi simili, addomesticabile solo con la paura esercitata da Stato aggressivo; per Jean-Jacques Rousseau, invece, la natura umana, di per sé buona, è stata incattivita dall’oppressione delle leggi dello Stato. In questa diatriba politica, le due ideologie, apparentemente contrapposte, sono in realtà complementari se trattate su una matrice scientifica: l’aggressione proattiva giustifica il pensiero di Hobbes, al contrario quella reattiva legittima il giudizio di Rousseau.
L’aggressività non è solo il linguaggio del crimine, una propensione “contro natura”, ma è proprio un’espressione della natura stessa, l’esibizione dell’istinto di sopravvivenza: uno slancio indirizzato alla conservazione di se stessi e della specie, un impulso spontaneo, una manifestazione di forza vitale che si esprime mediante un linguaggio istintivamente violento, che condivide con molti dei sentimenti umani la duplice natura razionale e irrazionale, senza la quale la natura stessa non potrebbe esistere.
Come affermava Friedrich Nietzsche, “L’irrazionalità di una cosa non è un argomento contro la sua esistenza anzi ne è una condizione”.