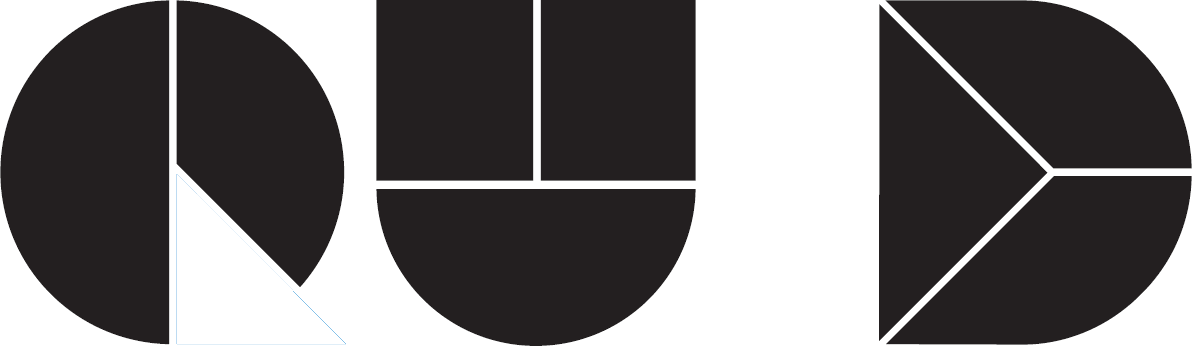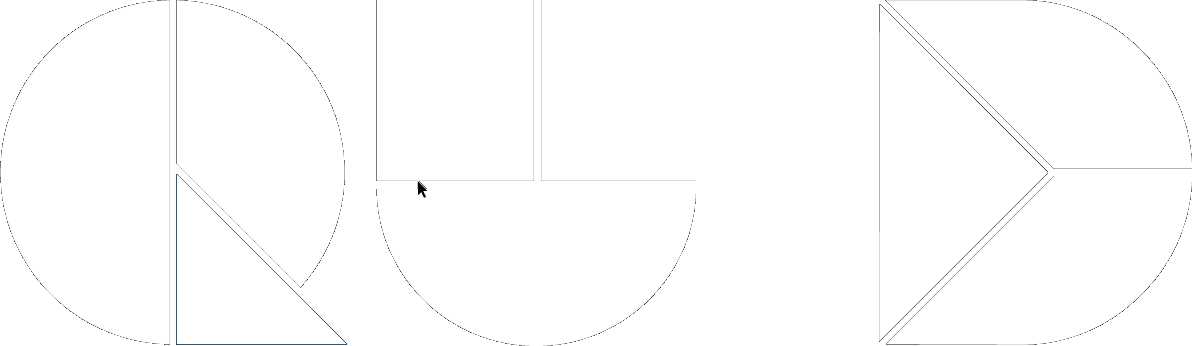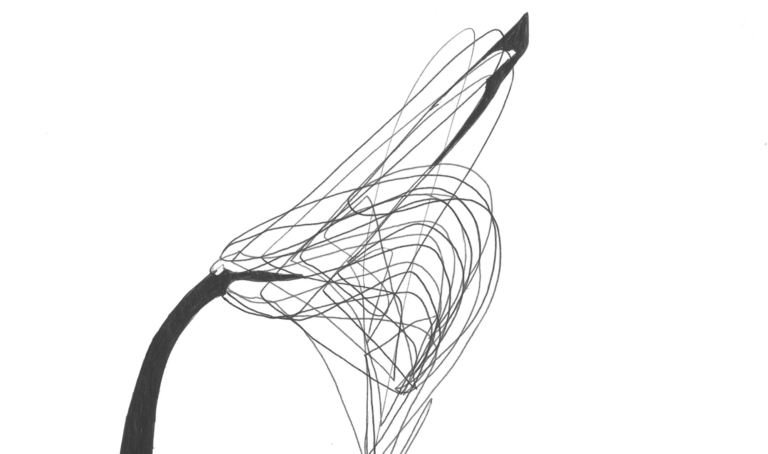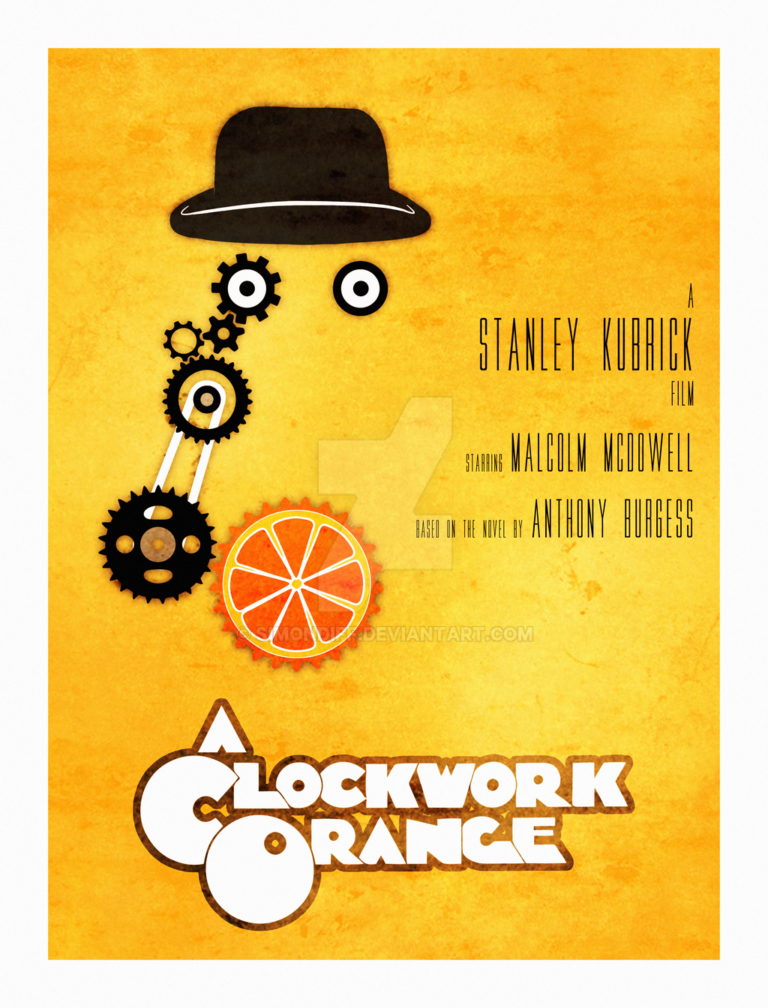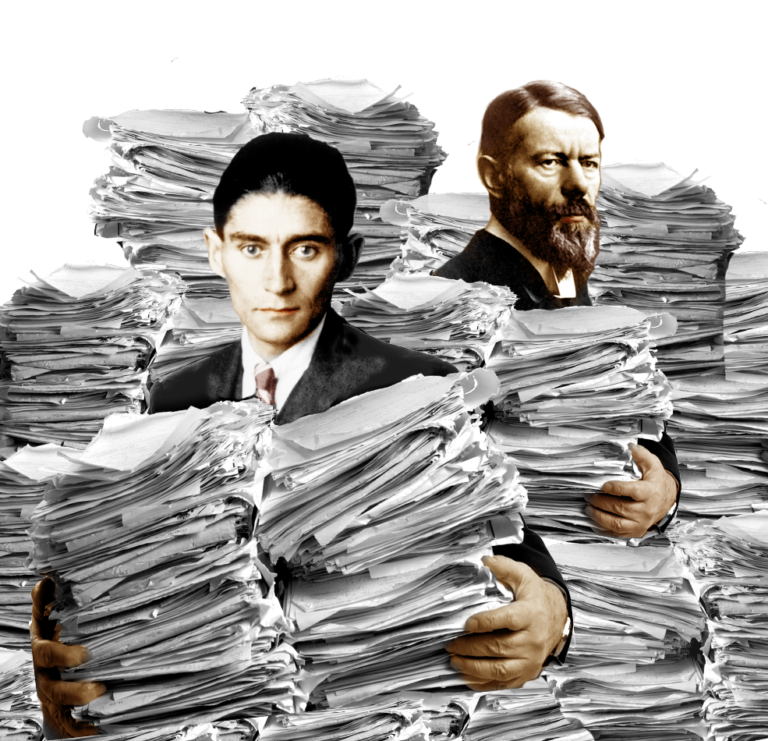Irene Facheris è formatrice, attivista, scrittrice e podcaster esperta in studi di genere.
Autrice dei libri Creiamo Cultura Insieme: 10 cose da sapere prima di iniziare una discussione, Parità in pillole. Impara a combattere le piccole e grandi discriminazioni quotidiane e Noi c’eravamo. Il senso di fare attivismo, è di recente uscito il suo ultimo podcast Tutti gli uomini: voci maschili si raccontano per cambiare.
L’abbiamo incontrata per discutere con lei di linguaggio inclusivo.
Cosa si intende per linguaggio inclusivo di genere? Puoi farci degli esempi?
Si tratta di un linguaggio che non dimentica nessuna persona. In italiano usiamo il maschile sovraesteso che, attenzione, non è il neutro. In tal senso “buongiorno a tutti” è un saluto che include anche le donne presenti.
Una proposta è stata quella di nominare anche il femminile. Tuttavia, dicendo “buongiorno a tutti e buongiorno a tutte” noi non nominiamo tutte le persone perché sappiamo, e se non lo sappiamo è un buon momento per impararlo, che esistono persone non binarie, che, immaginando maschile e femminile come uno spettro, non si sentono agli estremi né da una parte né dall’altra.
Una proposta recente è l’utilizzo dello schwa, che è un suono che noi in realtà in Italia già abbiamo, soprattutto nei dialetti del sud. Un mio carissimo amico mi dice sempre che per imparare a dire lo schwa basta dire mammt. Quel suono che percepisci tra la M e la T è esattamente lo schwa.
Se io dico “buongiorno a tuttə” sto quindi dando il buongiorno agli uomini, alle donne, alle persone non binarie. Chiaramente lo schwa ha dei limiti, tra cui la difficoltà di scrittura, l’impossibilità al momento di essere letto dalle app che trasformano i testi in suoni, però abbiamo un’alternativa. L’italiano ci permette di trovare degli escamotage. Se io dico “buongiorno a tutte le persone presenti”, sto parlando di chiunque. Ed è un modo che permette di far sentire le persone viste, considerate.
È così importante il linguaggio? Cosa rispondi a chi afferma che è più produttivo concentrarsi su altre battaglie (come quella sul pay gap) rispetto a quella sulle professioni al femminile?
Quel giorno che diranno “purtroppo devi occuparti solo di tre cose”, allora diremo “ok, qual è la cosa più grave?”. Ma oggi io non vedo il senso di dire “non occupiamoci di A perché dobbiamo occuparci di B”. Piuttosto occupiamoci di A e di B, visto che possiamo farlo.
Dopodiché, tu citi l’esempio del pay gap, e a mio avviso c’è una connessione tra le varie discriminazioni. Il fatto che le donne vengano pagate meno ha un collegamento con il fatto che ci si ostini a non utilizzare il femminile per le professioni. Femminile, che ricordiamo, esiste.
Se vado a zappare la terra sono una contadina, se ho le chiavi della città sono una sindaca. Se so dire segretaria e so dire schiava, non vedo perché non dovrei saper dire architetta, ingegnera, capa. Quindi quando sentiamo così tanta resistenza dovremmo chiederci perché.
È un caso che facciamo fatica a declinare al femminile le mansioni di potere ma non quelle umili? Probabilmente no. Dopodiché, continuando a chiamare al maschile le donne, continuiamo a ribadire inconsciamente che il maschile è più importante. E dunque se il maschile è più importante, poi non ci dobbiamo stupire che gli uomini vengano pagati di più.
Parliamo ora del linguaggio dell’attivismo femminista, si ha un po’ la sensazione che tanti lo liquidino come qualcosa di fastidioso, bollando le attiviste come persone rompiscatole. Penso per esempio al dilemma uomo vs orso, secondo alcuni una provocazione inaccettabile che ha messo sotto una cattiva luce gli uomini. È importante il modo di porsi o contano solo le istanze che si portano avanti?
Esiste sicuramente un lato dell’attivismo che ha un po’ di spocchia e questo atteggiamento di superiorità non è utile a nessuna persona, però va anche detto che ciò si ritrova anche nel mondo del lavoro o in altri contesti in cui siano presenti delle persone e quindi dinamiche di potere.
Se però come modo di porsi intendiamo non infiocchettare le cose, forse è il caso di dirsi le cose come stanno. Altrimenti come facciamo a cambiarle? Ad alcune persone questa cosa dà fastidio, perché se vedi una persona che sta cercando di cambiare le cose, quella persona ti ricorda che tu non lo stai facendo, quindi devi fare i conti con il tuo sentirti non abbastanza.
La questione uomo versus orso è semplice da capire. Se non la si capisce è perché si è scelto di non farlo. Nessuno sta dicendo “sei nel bosco, preferiresti incontrare un brav’uomo o un orso?”. La domanda è diversa ed è riassumibile con “preferiresti incontrare un uomo di cui non sai niente, che potrebbe essere il peggior uomo sulla faccia della terra o un orso di cui non sei niente e che potrebbe essere il peggior orso sulla faccia della terra?”. Al che le donne scelgono un orso. Io devo pensare al worst case scenario, ovvero nel caso peggiore un orso mi ammazza. Nel caso peggiore, invece, un uomo fa di peggio, può fare di peggio prima di ammazzarmi e dopo avermi uccisa. Questa non è fantascienza, è cronaca.
Se non capisci perché viene fatta questa domanda e come mai moltissime donne scelgano l’orso o è un problema di comprensione oppure hai capito perfettamente, ma non ti piace quello che stai ascoltando, non ti interessa, perché vivi così tanto nel tuo previlegio che quella cosa non ti toccherà mai o lo farà in maniera marginale.
Tra le altre cose, ti occupi di formazione in ambito diversity, toccando argomenti quali cultura LGBTQIA+, maschismo e discriminazione. In questa attività, qual è la tua esperienza sui temi del linguaggio inclusivo? Perché è così complicato spiegare che non si dovrebbe usare l’articolo prima del cognome di una donna?
Parto dalla fine. Michela diceva “la Murgia è un altopiano. Io sono Murgia”.
L’articolo si mette davanti agli oggetti, non davanti alle persone e non è un caso che venga messo davanti ai cognomi delle donne, non degli uomini, infatti sono le donne che sono oggettificate continuamente e non gli uomini. Siccome dicendo le cose in un certo modo si passano alcuni concetti, perché le parole sono la casa dei pensieri, è un problema mettere l’articolo davanti, perché ti abitui a pensare che quella cosa sia un oggetto.
Dopodiché, in merito alla mia esperienza, le aziende e le organizzazioni che mi contattano almeno ci provano, tanto di cappello. Poi ci sono alcuni scivoloni che mi fanno un po’ ridere, come per esempio inviare una mail alle persone che lavorano in azienda per dire che ci sarà un incontro sul linguaggio inclusivo e iniziarla con “ciao a tutti”.
A meno che non cominci a interessarti al tema, non fai uno switch nel cervello, quindi semplicemente certe cose non le vedi. Anche perché la società cerca di nasconderle, non aiuta a indossare quel paio di lenti, le lenti adatte per guardare determinate cose.
Il lato positivo è che, dopo che invece hai inforcato quegli occhiali, è difficile tornare a non vedere più certe cose.
Pensi che sia aumentata o diminuita l’attenzione delle nuove generazioni nei confronti del linguaggio inclusivo?
Sicuramente è aumentata perché sono aumentate le persone che fanno coming out rispetto alla loro identità di genere e dunque stanno facendo diventare il dibattito qualcosa di banale, normale, nel senso statistico del termine.
Al liceo non ho mai incontrato nessuna persona che si presentasse come non binaria e chiedesse di utilizzare pronomi neutri nei suoi confronti. E invece adesso ci sono persone giovani che hanno identità di genere non binaria e lo dicono. Ora non è più teoria. È il tuo compagno di banco.
Per forza di cose, diventa più semplice perché fa parte della tua quotidianità. Vent’anni fa c’erano persone non binare ma non lo dicevano. O perché non avevano le parole per dirlo. O per timore – comprensibilissimo – delle reazioni.
Adesso i tempi stanno cambiando. Stiamo andando a passo di lumaca, però non è vero che siamo fermi.
Cosa può fare ciascuno di noi per incrementare l’inclusività?
Il linguaggio è sicuramente un primo step importante. Se sono l’unica a utilizzare lo schwa o a cercare di rigirare le frasi così da non dover nominare il genere, dopo un po’ smetto di farlo perché mi posso sentire strana, avere la sensazione che nessuna persona stia apprezzando il mio tentativo.
Quando incontro un’altra persona che utilizza lo schwa, dice delle cose che fanno capire che si sta sforzando di non andare col pilota automatico, che ci porterebbe a utilizzare il maschile sovraesteso e a dare per scontato una serie di cose, a ragionare per stereotipi, luoghi comuni e pregiudizi, allora magari mi viene voglia di continuare a farlo, perché ho la sensazione di non essere più sola.
E poi si dovrebbe imparare ad ascoltare le esperienze delle persone. Siamo convinti di sapere già tutto, appena una persona ti racconta qualcosa, non lasci neanche il tempo di finire perché devi dire “ah, sai che invece io” e ti perdi il racconto di una diversità, che magari avrebbe anche incrementato le tue nozioni e portato un arricchimento.